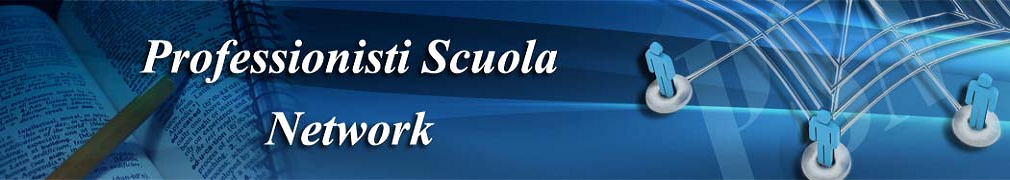1) La peculiarità di Thomas Hobbes (1588-1679) nel contesto della rivoluzione scientifica è l'essere stato uno dei primi ad averla estesa allo studio del comportamento e della società umana, mettendo da parte, come già fatto da Telesio, Bruno, Bacon, Cartesio, Galilei, i pregiudizi e le filosofie precedenti, ed utilizzando un approccio sistematico inteso a restituire una compatta e "totalizzante" visione del mondo che «avrebbe dovuto esporre le leggi della materia, dell'uomo e dello Stato con un metodo quanto più possibile deduttivo", simile a quello cartesiano, allo scopo, umanisticamente "tecnico", di «porre i fondamenti di una comunità ordinata e pacifica, che egli crede possibile soltanto sulla base di uno Stato assoluto».
Iscriviti alla nostra Fan page
2) Coerentemente con il presupposto materialistico secondo cui non esistono enti incorporei, e che tutti i fenomeni vanno spiegati in base al movimento di quelli corporei, per Hobbes la ragione, a differenza che per Cartesio, non costituisce «la facoltà di percepire chiaramente e distintamente le connessioni fra idee universali», propria di un'inverosimile sostanza pensante chissà come incastonata in quella estesa, ma bensì quella, propria degli esseri viventi e funzione della loro corporeità, di «appagare i propri bisogni e conservare la propria vita imparando dall'esperienza passata e prevedendo il futuro […] di prevedere e di progettare a lunga scadenza la propria condotta e ì mezzi per raggiungere i propri fini»: una capacità che, limitatamente presente negli ammali, negli uomini ha la massima esplicazione in virtù del possesso del linguaggio, ovvero di un complesso di segni arbitrari o convenzionali, le parole, che, indicando le idee, ovvero non la sostanza delle cose, ma le combinazioni di caratteri di volta in volta ritenuti più importanti di ciò di cui si fa esperienza sensibile e ritenute grazie alla memoria, e perciò costituenti una generalizzazione arbitraria di quelle passate, consentono un'efficace anticipazione di quelle future: «ad esempio, senza la parola 'triangolo', di fronte a ogni triangolo particolare ci si dovrebbe rendere conto delle sue proprietà: ma una volta inventata questa parola, si sa che ogni triangolo, comunque sia disegnato o formato, possiede le stesse proprietà: si ha cioè una generalizzazione che consente di abbracciare con un solo colpo d'occhio un numero indefinito di casi simili».
3) In quest'ottica la conoscenza, o il ragionamento, non è altro che sillogismo, ovvero messa in relazione, letteralmente calcolo, e, dunque addizione o sottrazione di idee o concetti, indicati da nomi generalmente, ma convenzionalmente, accettati dalla comunità scientifica (e, più in generale, dei parlanti); e così, ad esempio, se affermiamo che "gli Stati sono istituzioni", e "le istituzioni sono realizzazioni umane", ne arriviamo a concludere che "gli Stati sono realizzazioni umane", realizzando quella deduzione di un qualcosa dalla sua causa, ovvero da ciò che la fa accadere ("scire per causas") in cui, per Hobbes, essenzialmente si risolve la scienza.
4) Ciò implica anzitutto che quest'ultima non potrà mai comprendere la teologia, Dio non avendo causa; e quindi che la suddetta deduzione è certa solo se il suo oggetto è ciò di cui si è, anche in quanto specie, autori: le uniche conoscenze scientifiche possibili agli umani, di conseguenza, sono quelle matematiche o «morali, cioè la politica e l'etica […]. Infatti è l'uomo che costruisce le figure geometriche tracciandone a suo arbitrio le linee, cosi come è l'uomo che crea le cause della giustizia e dell'ingiustizia stabilendo le leggi e le convenzioni che sono alla base dell'etica e della politica»; laddove quella dei fenomeni naturali (progetto umanistico supremo) – essendone Dio la causa in ultima istanza, e noi non conoscendolo, ferma restando, cartesianamente, la necessaria coerenza con il principio dell'universale causalità del movimento, che pure, galileianamente, non è certo conosciuto a priori ma solo per via di generalizzazione dell'esperienza – si riduce al rango di mera probabilità, «poiché uno stesso effetto può essere prodotto da cause diverse»…
Per la lezione completa in PDF: Hobbes
Per qualsiasi dubbio, suggerimento, proposta scrivete a: viniciodintino@professionistiscuola.it
Guarda le altre lezioni o vai all'indice:

 1) L'importanza di Galileo Galilei (1564-1642) sta per un verso nell'elaborazione della metodologia della ricerca scientifica moderna, capace di sintetizzare le esigenze e superare le realizzazioni di Bacon e Cartesio, per un altro nelle sue indagini fisiche ed astronomiche da quella rese possibili e per un altro ancora in una battaglia culturale volta ad affermare l'autonomia della scienza nei confronti del sapere tradizionale – e dei suoi rappresentanti – e delle autorità religiose, nella fattispecie dalla interpretazione della Bibbia operata dalla Chiesa Cattolica – a cui pure egli non intendeva nuocere ma, piuttosto, giovare, nella persuasione che la religione, "rimanendo ancorata a tesi dichiarate false dal progresso scientifico, avrebbe inevitabilmente finito per squalificarsi dinanzi agli occhi dei credenti".
1) L'importanza di Galileo Galilei (1564-1642) sta per un verso nell'elaborazione della metodologia della ricerca scientifica moderna, capace di sintetizzare le esigenze e superare le realizzazioni di Bacon e Cartesio, per un altro nelle sue indagini fisiche ed astronomiche da quella rese possibili e per un altro ancora in una battaglia culturale volta ad affermare l'autonomia della scienza nei confronti del sapere tradizionale – e dei suoi rappresentanti – e delle autorità religiose, nella fattispecie dalla interpretazione della Bibbia operata dalla Chiesa Cattolica – a cui pure egli non intendeva nuocere ma, piuttosto, giovare, nella persuasione che la religione, "rimanendo ancorata a tesi dichiarate false dal progresso scientifico, avrebbe inevitabilmente finito per squalificarsi dinanzi agli occhi dei credenti".
 Mentre la riflessione protagorea, tutto sommato, non era andata a toccare le questioni tipiche delle filosofie precedenti, pur ponendo le premesse per la loro messa in discussione, quella di Gorgia da Lentini (485-376) lo fa nella maniera più radicale: e così, mentre i primi filosofi, pur nelle diverse soluzioni che avevano fornito al problema dell'arché, erano almeno stati accomunati dalla persuasione della sua esistenza, e dunque della possibilità della sua conoscenza, e quelli immediatamente successivi avevano ritenuto, contro Parmenide, che fosse possibile una spiegazione certa e inoppugnabile anche del mondo che ci circonda, Gorgia afferma, con la massima radicalità, che «nulla è; se anche qualcosa fosse non sarebbe conoscibile; se anche fosse conoscibile non sarebbe comunicabile»...
Mentre la riflessione protagorea, tutto sommato, non era andata a toccare le questioni tipiche delle filosofie precedenti, pur ponendo le premesse per la loro messa in discussione, quella di Gorgia da Lentini (485-376) lo fa nella maniera più radicale: e così, mentre i primi filosofi, pur nelle diverse soluzioni che avevano fornito al problema dell'arché, erano almeno stati accomunati dalla persuasione della sua esistenza, e dunque della possibilità della sua conoscenza, e quelli immediatamente successivi avevano ritenuto, contro Parmenide, che fosse possibile una spiegazione certa e inoppugnabile anche del mondo che ci circonda, Gorgia afferma, con la massima radicalità, che «nulla è; se anche qualcosa fosse non sarebbe conoscibile; se anche fosse conoscibile non sarebbe comunicabile»...

1) L'importanza di Bernardino Telesio (1509-88) sta nell'aver contribuito a preparare la rivoluzione scientifica, se non sul piano delle realizzazioni concrete, su quello dei suoi presupposti concettuali e metodologici, consistenti nella preliminare messa in discussione delle concezioni tradizionali e nella successiva indicazione delle modalità di sviluppo di una conoscenza proficua.
2) Sin il titolo della sua opera principale, La natura secondo i suoi propri principi, costituisce una polemica con l'allora dominante aristotelismo, incapace di indagare la natura, "costringendola" in concetti razionalistici, astratti e arbitrari (anima, materia, forma, essenza, etc.), anziché considerarla in sé stessa.
 1) Nonostante il capolavoro di Schopenhauer (1788-1860), Il mondo come volontà e rappresentazione, che esprimeva il suo pensiero in forma pressoché compiuta, sia stato pubblicato nel 1819, sarebbe dovuto trascorrere un trentennio perché attirasse l'attenzione del pubblico, specialista e non, a causa del suo porsi in totale controtendenza con le principali correnti culturali della prima metà del secolo, caratterizzate da un ottimismo per più versi analogo: l'hegelismo, con la concezione dell'essenziale razionalità della realtà, manifestantesi nell'incedere della storia umana verso il sempre più compiuto dispiegamento della libertà, ed il positivismo, con l'esaltazione del progresso tecnico-scientifico. Fu il fallimento delle rivoluzioni quarantottesche ed il naufragio dei loro ideali ad aprire uno spazio a posizioni più o meno irrazionalistiche ed esistenzialistiche, ripiegate sulla condizione del singolo, volte alla messa in luce del carattere caotico e doloroso della realtà che egli concretamente vive, e di conseguenza alla denuncia dell'illusorietà delle concezioni appena ricordate.
1) Nonostante il capolavoro di Schopenhauer (1788-1860), Il mondo come volontà e rappresentazione, che esprimeva il suo pensiero in forma pressoché compiuta, sia stato pubblicato nel 1819, sarebbe dovuto trascorrere un trentennio perché attirasse l'attenzione del pubblico, specialista e non, a causa del suo porsi in totale controtendenza con le principali correnti culturali della prima metà del secolo, caratterizzate da un ottimismo per più versi analogo: l'hegelismo, con la concezione dell'essenziale razionalità della realtà, manifestantesi nell'incedere della storia umana verso il sempre più compiuto dispiegamento della libertà, ed il positivismo, con l'esaltazione del progresso tecnico-scientifico. Fu il fallimento delle rivoluzioni quarantottesche ed il naufragio dei loro ideali ad aprire uno spazio a posizioni più o meno irrazionalistiche ed esistenzialistiche, ripiegate sulla condizione del singolo, volte alla messa in luce del carattere caotico e doloroso della realtà che egli concretamente vive, e di conseguenza alla denuncia dell'illusorietà delle concezioni appena ricordate.

1) Democrito (460-370 a.C.) fu l'esponente più noto della scuola fondata da Leucippo di Mileto, i cui autori non sono facilmente distinguibili e la cui importanza sta nell'aver costituito una grande alternativa a quella platonico-aristotelica, che se non produsse influenze immediate almeno mise fine all'apparente vanogioco della confutazione reciproca tra esponenti dello stesso filone di ricerca, mettendo a punto un filone di ricerca che sarebbe stato ripreso agli albori della rivoluzione scientifica, prima in maniera non dichiarata e poi, agli inizi dell'800, esplicitamente, dal fisico e chimico John Dalton, venendo infine abbandonata solo un secolo dopo, in seguito alla scoperta del fenomeno della radioattività, che dimostrava che ciò che, riprendendo l'antica lezione, era stato denominato "atomo" era in realtà un entità composita e di natura non semplicemente "materiale".
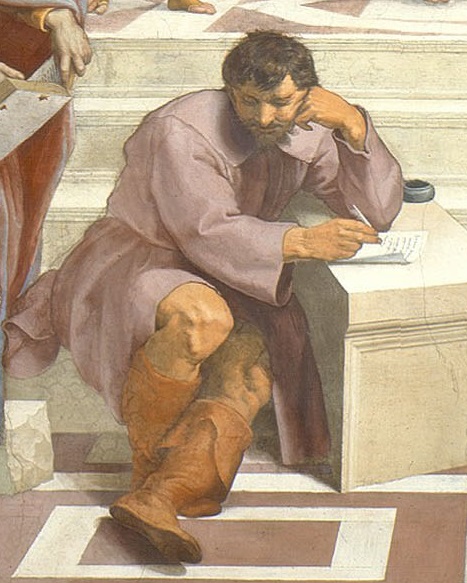 1) Eraclito (VI-V secolo) è il primo a dichiarare la convinzione da cui implicitamente muovevano i pensatori precedenti, ovvero la contrapposizione tra la riflessione filosofica, intesa come via d'accesso all'αρχή, e la mentalità comune, con ciò intendendo sia il complesso di conoscenze funzionali alla quotidianità che quella delle "autorità" tradizionali (intellettuali di prestigio, anziani) e dei cultori di tecniche e discipline specialistiche: tutti accomunati dall'impossibilità di accedere – anche se, presumibilmente, solo in quanto specialisti – alla visione della profonda unità delle cose, e dall'illusoria credenza nella loro separazione: "il sapere molte cose non insegna a pensare in modo retto; altrimenti lo avrebbe insegnato a Esiodo, a Pitagora e altresì a Senofane e a Ecateo. Esiste una sola sapienza: riconoscere l'intelligenza che governa tutte le cose attraverso tutte le cose".
1) Eraclito (VI-V secolo) è il primo a dichiarare la convinzione da cui implicitamente muovevano i pensatori precedenti, ovvero la contrapposizione tra la riflessione filosofica, intesa come via d'accesso all'αρχή, e la mentalità comune, con ciò intendendo sia il complesso di conoscenze funzionali alla quotidianità che quella delle "autorità" tradizionali (intellettuali di prestigio, anziani) e dei cultori di tecniche e discipline specialistiche: tutti accomunati dall'impossibilità di accedere – anche se, presumibilmente, solo in quanto specialisti – alla visione della profonda unità delle cose, e dall'illusoria credenza nella loro separazione: "il sapere molte cose non insegna a pensare in modo retto; altrimenti lo avrebbe insegnato a Esiodo, a Pitagora e altresì a Senofane e a Ecateo. Esiste una sola sapienza: riconoscere l'intelligenza che governa tutte le cose attraverso tutte le cose".
2) Impropriamente definito, dalla tradizione, il "filosofo del divenire" – come se la consapevolezza del cambiamento non fosse qualcosa di originario! –, Eraclito, piuttosto, come tutti i filosofi, ne prende le mosse, e denomina tale subentrare della diversità come "successione dei contrari", intendendo il termine "contrario", in senso ampio, come sinonimo di "diverso": il che significa che sarebbe improprio affermare, esemplificando, che al giorno segua la notte, alla luce il buio, alla vita la morte, dovendosi piuttosto dire che al giorno segue il "non giorno", alla luce la "non luce", alla vita la "non vita"...
 1) La tesi fondamentale dell'esistenzialismo è che l'oggetto più proprio della filosofia è la concretezza della condizione umana; appunto per questo Jean Paul Sartre, nell'opera del 1946 L'esistenzialismo è un umanismo, afferma che "siamo su di un piano dove ci sono soltanto uomini". Heidegger (1889-1976) – spesso accostato, erroneamente, al pensiero esistenzialista – nella sua Lettera sull'umanismo (1949), prende le distanze da quest'assunto, rivendicando la specificità della propria posizione filosofica, per la quale "siamo su di un piano dove c'è principalmente l'Essere"; e la questione che l'ha occupato per tutta la vita è appunto quella del significato fondamentale dell'essere, problematico nonostante il fatto che, come si legge nell'opera del 1927 Essere e tempo (la prima che rese note al grande pubblico le ricerche del filosofo), in qualche modo tutti credono di sapere cosa significhi "essere". Ciascuno di noi, infatti, comprende senza problemi il significato di espressioni quali "Il cielo è azzurro", "Sono contento", "Non c'è tempo", e così via.
1) La tesi fondamentale dell'esistenzialismo è che l'oggetto più proprio della filosofia è la concretezza della condizione umana; appunto per questo Jean Paul Sartre, nell'opera del 1946 L'esistenzialismo è un umanismo, afferma che "siamo su di un piano dove ci sono soltanto uomini". Heidegger (1889-1976) – spesso accostato, erroneamente, al pensiero esistenzialista – nella sua Lettera sull'umanismo (1949), prende le distanze da quest'assunto, rivendicando la specificità della propria posizione filosofica, per la quale "siamo su di un piano dove c'è principalmente l'Essere"; e la questione che l'ha occupato per tutta la vita è appunto quella del significato fondamentale dell'essere, problematico nonostante il fatto che, come si legge nell'opera del 1927 Essere e tempo (la prima che rese note al grande pubblico le ricerche del filosofo), in qualche modo tutti credono di sapere cosa significhi "essere". Ciascuno di noi, infatti, comprende senza problemi il significato di espressioni quali "Il cielo è azzurro", "Sono contento", "Non c'è tempo", e così via.

1) Il Positivismo, nato "in Francia nella prima metà dell'Ottocento [nell'atmosfera culturale creatasi attorno alla prima grande scuola della borghesia industriale francese, l'Ècole Polytechnique] ed impostosi, [con il diffondersi dell'industrializzazione] a livello europeo e mondiale, nella seconda parte del secolo", fu una corrente culturale caratterizzata dall'esaltazione della scienza e delle sue applicazioni tecniche, giustamente considerate come essenza della rivoluzione industriale, a sua volta causa di trasformazioni sociali e dell'incremento – almeno potenziale – del benessere della maggioranza della popolazione.

1) I pensatori a cui si fa risalire l'inizio della filosofia furono denominati da Aristotele "fisiologi" o fisici, cioè naturalisti, studiosi della natura (φύσις).

1) Il pensiero di Parmenide di Elea (515-450 a. C.), autore di probabile formazione pitagorica e dell'opera in versi successivamente intitolata Intorno alla natura, sembra essere stato trasmesso in un'interpretazione fuorviante che, proprio per la sua diffusione, non può essere accantonata, nonostante la sua necessità e proprio in vista di un suo superamento.

1) La peculiarità di Thomas Hobbes (1588-1679) nel contesto della rivoluzione scientifica è l'essere stato uno dei primi ad averla estesa allo studio del comportamento e della società umana, mettendo da parte, come già fatto da Telesio, Bruno, Bacon, Cartesio, Galilei, i pregiudizi e le filosofie precedenti, ed utilizzando un approccio sistematico inteso a restituire una compatta e "totalizzante" visione del mondo che «avrebbe dovuto esporre le leggi della materia, dell'uomo e dello Stato con un metodo quanto più possibile deduttivo", simile a quello cartesiano, allo scopo, umanisticamente "tecnico", di «porre i fondamenti di una comunità ordinata e pacifica, che egli crede possibile soltanto sulla base di uno Stato assoluto».
 1) Anassagora (500-428 a.C.) radicalizzò il tema parmenideo dell'impossibilità del passaggio dal non essere all'essere, affermando che i principi, da lui definiti semi, fossero di generi tanti e tanto vari quanto le differenze tra ed all'interno delle cose; inoltre, recependo l'istanza zenoniana, concepì tali semi come infinitamente divisibili (e perciò costituenti una massa infinita), in parti che però mantengono la loro stessa natura: così, ad esempio, le parti in cui si divide il seme del legno saranno esse stesse lignee. Per questa ragione Aristotele denominò i semi omeomerie, che significa appunto "parti simili [al tutto che compongono]". Anche in questa concezione, ovviamente, la nascita e la morte sarebbero, come tali, illusorie, perché equivalenti soltanto a composizione e scomposizione dei semi.
1) Anassagora (500-428 a.C.) radicalizzò il tema parmenideo dell'impossibilità del passaggio dal non essere all'essere, affermando che i principi, da lui definiti semi, fossero di generi tanti e tanto vari quanto le differenze tra ed all'interno delle cose; inoltre, recependo l'istanza zenoniana, concepì tali semi come infinitamente divisibili (e perciò costituenti una massa infinita), in parti che però mantengono la loro stessa natura: così, ad esempio, le parti in cui si divide il seme del legno saranno esse stesse lignee. Per questa ragione Aristotele denominò i semi omeomerie, che significa appunto "parti simili [al tutto che compongono]". Anche in questa concezione, ovviamente, la nascita e la morte sarebbero, come tali, illusorie, perché equivalenti soltanto a composizione e scomposizione dei semi.

1) Socrate, pur condividendo la persuasione sofista dell'impossibilità di discorsi "definitivi", cercò di superarne il relativismo, tendenzialmente foriero di una politica "ingiusta", cioè basata essenzialmente sulla forza e sulla sopraffazione reciproca, concentrandosi sulla definizione rigorosa dei problemi etico-politici, la cui autentica dimensione era da acquisire proprio in quell'inesauribile processo dialogico che idealmente rispecchiava la democrazia della polis.
2) Per il suo allievo Platone (427-347 a.C.), invece, era proprio quest'ultima ad essere essenzialmente causa di ingiustizia, giacché il suo presupposto relativistico – ovvero la persuasione che chiunque potesse legittimamente esercitare il potere –, abbinato alla verosimile impossibilità che tutti fossero virtuosi, cioè filosofi nel senso socratico, costituiva un terreno fertile per l'affermazione di politici senza scrupoli come Callicle.
3) Tutto ciò era stato, nella sua ottica, alla base della crisi del sistema delle polis, effettivamente indebolite dai conflitti tra le diverse fazioni, spesso al limite della guerra civile, dalla continua esposizione all'instabilità dei regimi corrotti e all'insostenibilità di quelli più o meno larvatamente tirannici (esemplare, in tal senso, la sorte di Socrate), dai contrasti esterni dovuti alle conseguenti ambizioni egemoniche (si pensi alla rivalità tra Sparta ed Atene) che ne minacciavano l'indipendenza tanto quanto la pressione di imperi stranieri (dopo aver fronteggiato a fatica la minaccia persiana, nel giro di un paio di generazioni le città greche sarebbero state assorbite nell'impero macedone, perdendo ogni autonomia).

1) Per introdurre il pensiero di Karl Marx (1818-83) è opportuno ricordare che il suo sodale Friedrich Engels (1820-95) affermò, nel discorso funebre a lui dedicato, che egli fu anzitutto un rivoluzionario: gli aspetti economici, sociologici giuridici, storici e filosofici dei suoi studi costituiscono i diversi ed organici momenti di un progetto politico complessivo volto alla comprensione – e, perciò stesso, alla promozione – del processo in atto nella società contemporanea, che per lui avrebbe determinato l'abbattimento del sistema economico capitalista da parte del proletariato, classe sociale da esso stesso generata, e quindi la sua instaurazione di una società comunista.
 1) Il pensiero di Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) è, come quello di Schopenhauer, di Freud, di Marx e di Kierkegaard, una radicale messa in discussione e demistificazione dei tradizionali valori culturali, filosofici, etici, religiosi e politici della storia occidentale, e per questo motivo è ben rappresentativo del suo periodo più che secolare di crisi e trasformazione, caratterizzato dall'affermazione su scala mondiale della borghesia e del capitalismo che, ben lungi dal realizzare i sogni degli illuministi e dei positivisti, hanno determinato, oltre al rapidissimo abbandono di vecchie consuetudini, spesso non sostituite da alcunché o da atteggiamenti peggiori, nuove motivazioni ed occasioni, via via più drammatiche, di angosce individuali e conflittualità inter- ed intra-statuali, e nuove forme politiche, più o meno "totalitarie" ma in ogni caso estremamente pervasive, che costituiscono nel complesso un motivo più che legittimo per dubitare della "razionalità" e "sensatezza" del mondo umano e del suo percorso ed, in ogni caso, ricercare delle soluzioni.
1) Il pensiero di Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) è, come quello di Schopenhauer, di Freud, di Marx e di Kierkegaard, una radicale messa in discussione e demistificazione dei tradizionali valori culturali, filosofici, etici, religiosi e politici della storia occidentale, e per questo motivo è ben rappresentativo del suo periodo più che secolare di crisi e trasformazione, caratterizzato dall'affermazione su scala mondiale della borghesia e del capitalismo che, ben lungi dal realizzare i sogni degli illuministi e dei positivisti, hanno determinato, oltre al rapidissimo abbandono di vecchie consuetudini, spesso non sostituite da alcunché o da atteggiamenti peggiori, nuove motivazioni ed occasioni, via via più drammatiche, di angosce individuali e conflittualità inter- ed intra-statuali, e nuove forme politiche, più o meno "totalitarie" ma in ogni caso estremamente pervasive, che costituiscono nel complesso un motivo più che legittimo per dubitare della "razionalità" e "sensatezza" del mondo umano e del suo percorso ed, in ogni caso, ricercare delle soluzioni.
 1) Come nel caso di filosofi come Socrate o Giordano Bruno, l'importanza della vita di Kierkegaard (1813-55) – condotta solitariamente, "permeata da un profondo senso del peccato" (Abbagnano-Fornero) concretizzantesi in un oppressivo senso di colpa, e caratterizzata, negli ultimi anni, dalla "polemica contro la Chiesa protestante danese" (Abbagnano-Fornero), giudicata, a causa della sua "mondanizzazione", del tutto distante dall'autenticità religiosa – sta nell'attestazione del rilievo pratico, ovvero delle ricadute sul piano esistenziale (e non "politico", come nel caso dei due sopracitati) del suo pensiero, destinato ad una più che consistente fortuna postuma allorquando, più di mezzo secolo dopo, si sarebbe venuto a costituire un contesto ideale per la sua ricezione, testimoniata dalla ripresa da parte delle filosofie "esistenzialiste".
1) Come nel caso di filosofi come Socrate o Giordano Bruno, l'importanza della vita di Kierkegaard (1813-55) – condotta solitariamente, "permeata da un profondo senso del peccato" (Abbagnano-Fornero) concretizzantesi in un oppressivo senso di colpa, e caratterizzata, negli ultimi anni, dalla "polemica contro la Chiesa protestante danese" (Abbagnano-Fornero), giudicata, a causa della sua "mondanizzazione", del tutto distante dall'autenticità religiosa – sta nell'attestazione del rilievo pratico, ovvero delle ricadute sul piano esistenziale (e non "politico", come nel caso dei due sopracitati) del suo pensiero, destinato ad una più che consistente fortuna postuma allorquando, più di mezzo secolo dopo, si sarebbe venuto a costituire un contesto ideale per la sua ricezione, testimoniata dalla ripresa da parte delle filosofie "esistenzialiste".

1) Il fatto che il cristianesimo, in quanto religione rivelata, non fosse il risultato di una ricerca filosofica, non significava certamente che non gli si ponesse la necessità di chiarificare e sistemare organicamente le proprie concezioni; questo, insieme alle "esigenze di interpretazione dei testi sacri (ricchi di esempi, immagini figurate, allegorie) e di chiarificazione di punti complessi della dottrina, così come il confronto di alcuni [suoi] concetti fondamentali con quelli elaborati dalla filosofia" imponeva necessariamente un tipo di riflessione, a suo modo "filosofica", che avrebbe dunque potuto giovarsi della concettualità greca.

1) La filosofia da Talete ad Anassagora si era caratterizzata essenzialmente come "fisica", ossia come riflessione sulla natura; con la sofistica, invece, che tralasciò il problema dell'archè e concentrò la propria attenzione sull'uomo inteso non come ente biologico, "animale", ma a partire dalle problematiche legate alla vita associata, ovvero la morale, il diritto, la politica, la religione, nacque la sua prima specializzazione, origine remota delle discipline "umanistiche" contemporanee.
 1) La ricerca dei primi filosofi era stata orientata all'individuazione del principio di tutte le cose, inteso di volta in volta in senso sostantivo oppure verbale. La svolta che portò a considerarlo definitivamente nel primo senso fu determinata dall'ambiguità del pensiero parmenideo, che produsse la convinzione che gli enti sensibili fossero, semplicemente, "falsi", e che compito della ricerca filosofica fosse l'individuazione dell'unico ente realmente "vero", cioè disvelato alla ragione.
1) La ricerca dei primi filosofi era stata orientata all'individuazione del principio di tutte le cose, inteso di volta in volta in senso sostantivo oppure verbale. La svolta che portò a considerarlo definitivamente nel primo senso fu determinata dall'ambiguità del pensiero parmenideo, che produsse la convinzione che gli enti sensibili fossero, semplicemente, "falsi", e che compito della ricerca filosofica fosse l'individuazione dell'unico ente realmente "vero", cioè disvelato alla ragione.

1) Giurista tedesco, nato a Plettenberg (Westfalia) nel 1888, ed ivi spentosi nel 1985, la sua riflessione si colloca a ridosso delle due guerre mondiali, in un periodo in cui è ormai conclusa la da lui definita "epoca interstatale del diritto internazionale" ("jus publicum europaeum"), compresa tra il XVI secolo e la fine del XIX, e contrassegnata dal superamento delle guerre civili di religione del periodo immediatamente precedente e dalla conseguente trasformazione della guerra in "guerra tra Stati sovrani europei […] statalmente autorizzata e statalmente autorganizzata": il che significa che, in quel contesto storico la guerra, proprio come un "duello tra gentiluomini", non veniva considerata un'aggressione o un crimine, ma un legittimo confronto fra entità reciprocamente riconoscentisi come Stati sovrani, aventi cioè la potestà di decidere "intorno all'amicizia, ostilità, o neutralità reciproca".
 1) La riflessione di Giordano Bruno (1548-1600) costituisce il momento culminante dell'esaltazione umanistica dell'autoaffermazione intramondana dell'uomo – da Abbagnano-Fornero presentata, in maniera parziale e, perciò, fuorviante, come mero "amore per la vita", quasi suggerendo l'idea di una celebrazione romantico-esistenziale del piacere dei sensi – comportando, per la prima volta in più di mille anni, una serrata critica del cristianesimo, sia nella sua versione cattolica che in quella riformata, che determinò, assieme allo spirito spregiudicato ed anti-tradizionalista del filosofo, i suoi continui scontri con gli intellettuali della sua epoca, ed una vita tormentata ed errabonda che si concluse, drammaticamente, con il rogo – un esito ahimè inevitabile di cui Abbagnano e Fornero si dolgono molto meno che per il suo non "essersi riconciliato con il Crocefisso".
1) La riflessione di Giordano Bruno (1548-1600) costituisce il momento culminante dell'esaltazione umanistica dell'autoaffermazione intramondana dell'uomo – da Abbagnano-Fornero presentata, in maniera parziale e, perciò, fuorviante, come mero "amore per la vita", quasi suggerendo l'idea di una celebrazione romantico-esistenziale del piacere dei sensi – comportando, per la prima volta in più di mille anni, una serrata critica del cristianesimo, sia nella sua versione cattolica che in quella riformata, che determinò, assieme allo spirito spregiudicato ed anti-tradizionalista del filosofo, i suoi continui scontri con gli intellettuali della sua epoca, ed una vita tormentata ed errabonda che si concluse, drammaticamente, con il rogo – un esito ahimè inevitabile di cui Abbagnano e Fornero si dolgono molto meno che per il suo non "essersi riconciliato con il Crocefisso".

1) La cultura umanistico-rinascimentale, considerata unitariamente, si colloca storicamente tra la fine del '300 e quella del '500, ossia nel periodo delle varie fasi di sviluppo di forme istituzionali distinte da quelle medievali, gli Stati moderni, anzitutto quelli comunali prima e regionali poi in Italia e Germania, e quindi quelli nazionali in Francia, Spagna, Olanda e Inghilterra, destinati a sorti ben più luminose.
 1) Francis Bacon (1561-1626) si impegnò sia nell'esplicitazione dei motivi dell'importanza di quel dominio della natura auspicato da Giordano Bruno, sia nell'individuazione e celebrazione della scienza come dell'unico mezzo capace di raggiungerlo, intendendola come ricerca paziente e metodica, condotta da scienziati non isolati ma riuniti in gruppi di ricerca, e capace di produrre non conoscenze "pure" e "disinteressate" ma applicazioni tecniche progettate per il benessere dell'umanità, cioè per liberarla dai flagelli della miseria e delle malattie.
1) Francis Bacon (1561-1626) si impegnò sia nell'esplicitazione dei motivi dell'importanza di quel dominio della natura auspicato da Giordano Bruno, sia nell'individuazione e celebrazione della scienza come dell'unico mezzo capace di raggiungerlo, intendendola come ricerca paziente e metodica, condotta da scienziati non isolati ma riuniti in gruppi di ricerca, e capace di produrre non conoscenze "pure" e "disinteressate" ma applicazioni tecniche progettate per il benessere dell'umanità, cioè per liberarla dai flagelli della miseria e delle malattie.
 1) L'attenzione del giovane Sigmund Freud (1856-1939) per gli studi del neuropsichiatra francese Jean Martin Charcot fu determinata dal fatto che questi, a differenza dei suoi colleghi di scuola positivista, prendeva in seria considerazione anche gli stati psiconevrotici (quali paralisi, convulsioni, attacchi epilettici, anoressia, bulimia, etc.) non riconducibili a lesioni organiche, ma a processi psichici autonomi, sforzandosi di curarli per mezzo dell'ipnotismo.
1) L'attenzione del giovane Sigmund Freud (1856-1939) per gli studi del neuropsichiatra francese Jean Martin Charcot fu determinata dal fatto che questi, a differenza dei suoi colleghi di scuola positivista, prendeva in seria considerazione anche gli stati psiconevrotici (quali paralisi, convulsioni, attacchi epilettici, anoressia, bulimia, etc.) non riconducibili a lesioni organiche, ma a processi psichici autonomi, sforzandosi di curarli per mezzo dell'ipnotismo.
 1) Il pensiero di Immanuel Kant (1724-1804) costituisce il punto di confluenza e la sintesi delle tematiche dell'empirismo e del razionalismo, configurandosi così come momento culminante della filosofia moderna (e, più in particolare, dell'Illuminismo) e, al tempo stesso, luogo d'origine di quella contemporanea.
1) Il pensiero di Immanuel Kant (1724-1804) costituisce il punto di confluenza e la sintesi delle tematiche dell'empirismo e del razionalismo, configurandosi così come momento culminante della filosofia moderna (e, più in particolare, dell'Illuminismo) e, al tempo stesso, luogo d'origine di quella contemporanea.
2) Nei suoi studi giovanili Kant era stato influenzato dall'ideale illuminista di una filosofia naturalistica fondata sulla fisica newtoniana, e come quella impegnata ad evitare l'introduzione di cause e forze trascendenti la semplice descrizione dei fenomeni.
3) Restava tuttavia l'esigenza di una fondazione razionalistica di tale filosofia, che, pur consapevole della strutturale limitatezza della ragione umana messa in luce dall'empirismo, fosse tuttavia capace di evitarne l'esito scettico e, tendenzialmente, irrazionalistico, che in ultima analisi poteva pregiudicare la stessa attendibilità della conoscenza scientifica.
 1) Intercorrono quattro secoli fra l'epoca di Sant'Agostino e la nascita della filosofia "Scolastica", così detta perché sviluppatasi nei livelli superiori delle scuole medievali, organizzatesi a partire dall'età carolingia e caratterizzate dalla riflessione sui rapporti, variamente intesi, tra la fede cristiana e la ragione.
1) Intercorrono quattro secoli fra l'epoca di Sant'Agostino e la nascita della filosofia "Scolastica", così detta perché sviluppatasi nei livelli superiori delle scuole medievali, organizzatesi a partire dall'età carolingia e caratterizzate dalla riflessione sui rapporti, variamente intesi, tra la fede cristiana e la ragione.
2) Il presupposto generale è la "superiorità" della prima, e non l'inutilità della seconda che, come già era stato per Sant'Agostino, è fondamentale sia per comprendere ed ordinare le verità rivelate, sia per presentarle agli infedeli – cioè ai credenti nella giovane e potente nuova religione musulmana – facendo leva sulla loro accettabilità per la ragione.
3) Tommaso d'Aquino (1221-1274) costituisce il vertice della speculazione scolastica, fondando, sulla base dell'elaborazione aristotelica, un sistema filosofico tuttora fortemente presente nel pensiero cattolico.

1) Socrate (470-399 a. C.) intese la verità non come un complesso di conoscenze compiute, ma come il rigore formale di un processo dialogico caratterizzato da
a) preliminare riconoscimento dei pregiudizi, ovvero delle convinzioni implicite ed infondate sulla cui base ci si esprime su questioni di cui non si possiede una conoscenza effettiva: fingendo di concordare con il proprio interlocutore (ad esempio sulla concezione della giustizia), Socrate lo invita a passare da esemplificazioni particolari ad una definizione generale ("che cos'è la giustizia?"), per poi incalzarlo con una serie di interrogativi che, evidenziandone la contraddittorietà, lo spingono a rendersi conto della propria sostanziale ignoranza in merito ("sapere di non sapere") e della conseguente necessità di un ripensamento ed una
b) chiarificazione dei termini fondamentali del problema, in base alla quale si potrà procedere ad uno
c) svolgimento delle successive argomentazioni non contraddittorio con quanto stabilito e con lo stesso processo dialogico, evitando, cioè, la pretesa di "chiuderlo", ossia di sottrarsi all'eventuale necessità di ulteriori revisioni ed approfondimenti, pena la ricaduta in nuovi pregiudizi.
- 0

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

| [ ] |